…almeno a casa mia.
Dunque, stanco di avere la musica dispersa fra alcune migliaia di CD, altrettanti vinili e molti file su computer (tutti rigorosamente acquistati, CC o digitalizzati da dischi che possiedo), ho deciso di digitalizzare il tutto, metterlo su un HD in rete e utilizzare un vecchio portatile come jukebox (ovviamente con linux).
Un gran lavoro che, per ora, ho fatto solo su un quarto circa dell’insieme, il che spiega anche la non assidua continuità dei post di settembre.
Il sistema, alla fine, è composto da un sistema RAID da 2 terabytes (di cui si usa solo una piccola parte) letti da un portatile di vecchia generazione (avrà 5 anni, monoprocessore da 2.8 GHz) su cui gira un Ubuntu Jaunty con scheda M-Audio, collegata a un micro mixer che va a due casse auto-amplificate Event ALP 5 oppure Yamaha HS80M.
Come software uso Rhythmbox (sto provando anche Banshee). Il software si fa un database di tutto ciò che è audio e lo indicizza in base ai tag. Poi si possono selezionare i brani in base a autore, titolo e/o genere. Inoltre il computer è in rete, quindi si può ascoltare qualunque cosa si trovi su internet, comprese radio, netlabel, podcast etc.
Bene, considerando che la mia discoteca è alquanto eterogenea e va da Luigi Nono fino ai Sex Pistol, sono stato colpito dalla bassa qualità degli MP3. Con casse di questo tipo, che comunque sono lontane dal top, gli MP3 a 128 kbps risultano fastidiosamente ed evidentemente privi delle frequenze alte, non solo con la musica classica, ma anche ascoltando i Rolling Stones. Perfino a 192, la differenza con l’originale si sente e per avere qualcosa di accettabile bisogna arrivare almeno a 256 kbps.
Per quel che riguarda la musica classica, lo sapevo già, ma quello che mi ha colpito è che il degrado è sensibile anche con musica il cui punto di forza non è certamente la pulizia e la chiarezza del suono (tipo Rolling Stones, appunto). Notate che, al di là delle buone casse, non ho una stanza particolarmente insonorizzata o similia. È una stanza normale.
In effetti, all’inizio pensavo di convertire in FLAC (compressione senza perdita) gli album più raffinati e usare MP3 intorno ai 192 kbps, o meno, per il resto. Invece un po’ di prove mi hanno convinto (direi quasi costretto) a usare MP3 solo a 320 oppure con bitrate variabile alla massima qualità per i gruppi un po’ “rumorosi” e andare in FLAC per tutto il resto.
L’effetto collaterale è che non compro più musica in MP3 inferiore a 256 kbps e solo se il prezzo è basso. Altrimenti mi devono dare un file compresso ma senza perdita (FLAC, APE, LA).
La massificazione dell’MP3 si traduce in una perdita della qualità appena conquistata con il passaggio al CD. Magari lo sapevamo già, ma vederlo e sentirlo è un’altra cosa.


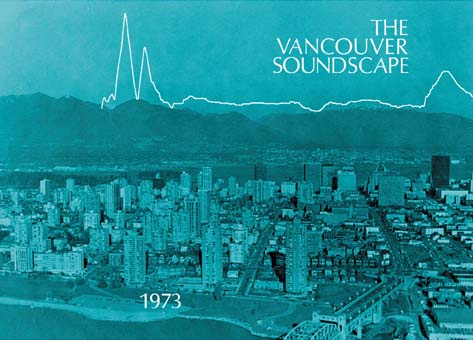 The
The 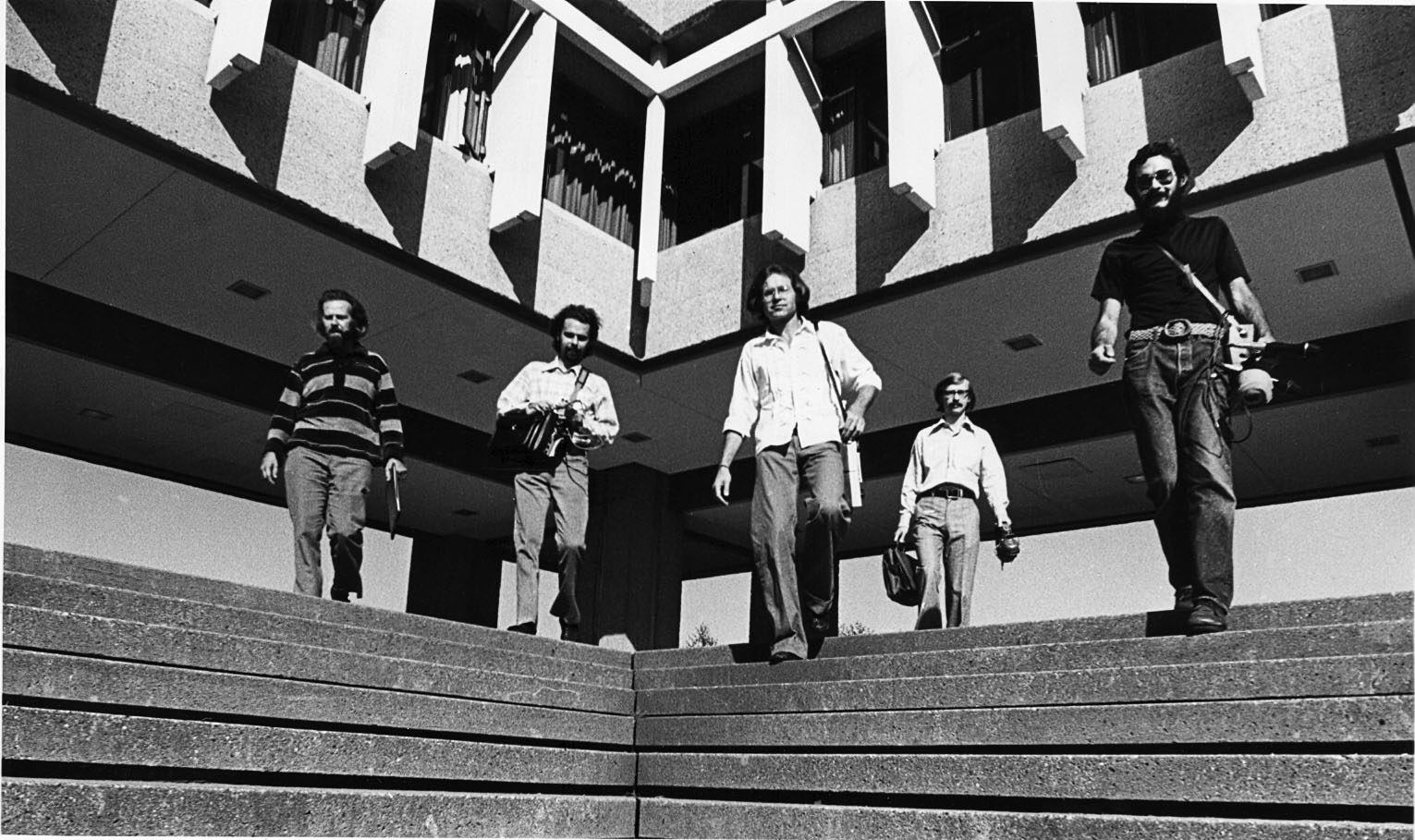
 Walter De Maria (nato ad Albany, in California, nel 1935) è uno dei principali esponenti della corrente artistica detta
Walter De Maria (nato ad Albany, in California, nel 1935) è uno dei principali esponenti della corrente artistica detta 